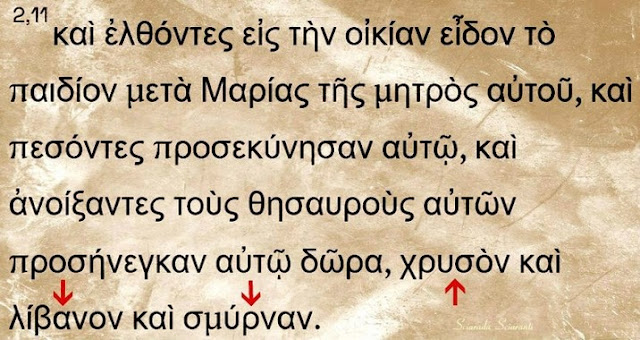" Sono nato a Rodi nel 1930. La chiamavano «l’isola delle rose», perché l’aria è pervasa dal loro profumo. Sono uno dei pochi fortunati a essere nato in questo bellissimo posto ...... Da quando, nel 1912, l’isola era finita sotto l’amministrazione di un governatore italiano, la situazione degli ebrei locali non era cambiata di molto. Rodi e l’intero arcipelago del Dodecaneso, un gruppetto di dodici isole greche a largo della Turchia, erano diventate parte dell’allora Regno d’Italia in seguito alla guerra italo-turca ...
... La comunità ebraica di Rodi aveva ottimi rapporti con gli italiani. Fra di loro, del resto, c’erano persone squisite con le quali andar d’accordo era la cosa più naturale al mondo. Qualcuno, soprattutto fra gli anziani, vedeva con un po’ di sospetto la nuova amministrazione, ma era solo un pregiudizio dell’età. Invecchiando diventa sempre più difficile digerire il cambiamento, anche quando è nettamente positivo.
Per tutta la durata del controllo turco, Rodi era rimasta molto indietro. La rete viaria era malandata e i sistemi elettrici e di fornitura dell’acqua erano quasi del tutto assenti. L’occupazione italiana, invece, portò molti vantaggi all’intera isola, trasformandola in un paradiso. Le strade presero una forma e divennero praticabili, corrente elettrica e acqua potabile non furono più una cosa di pochi. Venne istituita una prima rete di trasporti pubblici, mentre la città cambiava completamente profilo.
Gli italiani furono promotori di una serie di opere pubbliche che ancora oggi sono un vanto dell’isola: la ristrutturazione del castello dei cavalieri di Malta (che ormai era ridotto a un rudere), il Grande Albergo delle Rose (convertito in un casinò), le terme di Kalithea, l’ex teatro Puccini (oggi Nazionale), la Casa del Fascio (attualmente utilizzata come municipio), il Palazzo del Governo, la caserma dei carabinieri Principe di Piemonte (poi passata alla polizia greca) e tanto altro.
Prima che arrivassero gli italiani, tutte queste cose non c’erano ed è sotto la loro guida che Rodi si è definitivamente guadagnata il nome di «isola delle rose»... "
Per questo ho vissuto
Sami Modiano
Samuel detto Sami nasce da Diana e Giacobbe Modiano il 18 luglio del 1930 sull'isola di Rodi che a quel tempo era una provincia italiana in cui ebrei, cristiani e musulmani convivevano in pace.
Nel 1938 con la promulgazione delle leggi razziali viene espulso dalla terza elementare, la madre muore a causa di una malattia e il padre perde il lavoro.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 i tedeschi invadono Rodi e il 23 luglio del 1944 deportano tutti gli ebrei dell'isola, li imbarcano su un mercantile che raggiunge il Pireo; il 3 agosto del 1944 vengono ammassati sul treno per Birkenau e 13 giorni dopo, il 16 agosto del 1944, Sami, la sorella Lucia, tre anni più grande di lui e il padre entrano nel campo di sterminio, qui gli uomini vengono separati dalle donne:
" ... Mio papà aveva capito subito che ci stavano separando, allora ci teneva stretti stretti. Ma i tedeschi vennero e cercarono subito di strappare mia sorella Lucia dalle mani di mio padre, che la difendeva con tutte le sue forze. Lo presero a calci e a pugni, finché, poverino, dovette cederla. Non poteva fare altrimenti, non c’era altra possibilità. Io non riuscii a dire niente a Lucia, l’abbracciai, mi abbracciava… Fu uno strappo, un dolore vedere mio papà, poverino… fare tutto quel che poteva, ma invano ... "
Segue la selezione di Josef Mengele, prima quella delle donne; Lucia risulta idonea al lavoro e nella sua fila c'è:
" ... Una giovane donna ebrea di Rodi, avrà avuto venti, ventidue anni, che stringeva un neonato fra le braccia, era stata giudicata adatta al lavoro. Le strapparono quella creatura per buttarla dall’altra parte, con le vecchie. Noi non capivamo il perché, e nemmeno quella mamma sapeva che il suo piccolo sarebbe subito finito nelle camere a gas, mentre lei era stata scelta per andare a lavorare. Non capivamo, ma la crudeltà di ciò che stavano facendo a quelle donne era una tortura per tutti. Ancora oggi, quando ritorno sulla Rampa di Birkenau, questa scena la vedo davanti agli occhi ... "
Per questo ho vissuto
Sami Modiano
Viene il turno degli uomini e Sami non è idoneo al lavoro, se, nella confusione generale, il padre non l'avesse tratto a se sarebbe finito nelle camere a gas, invece diventa il numero B7456 ed è assegnato alla baracca 11 mentre il padre B7455 è assegnato alla 15.
" ... Cominciai a rischiare la vita per il cibo, spesso per andare a rubare le bucce di patate presso la cucina, di notte.
I tedeschi ogni tanto prendevano uno di noi per mandarlo a sbucciare patate. Anche in questo caso eravamo tenuti d’occhio da un soldato e non da un Kapo. I nazisti sapevano benissimo che quando si trattava di cibo non ci si poteva fidare di un Kapo: era sicuro che ne avrebbe «organizzato» un bel po’ e quelle patate erano per i soldati, mica per noi prigionieri. Con quel cibo non c’era da scherzare. Guai a mettersi una buccia in bocca mentre si era lì a pelare! La guardia ti avrebbe riempito di botte, o forse peggio.
Quando capitò a me, a fine giornata mi ordinarono di prendere tutte le bucce e di buttarle in un bidone fuori dalla cucina. Per me era come sputare su un tesoro. Con quelle bucce avrei sfamato un’intera baracca, però «organizzarle» lì davanti a loro era fuori discussione. Alzai il coperchio e buttai via tutto.
Tornato alla baracca non pensavo ad altro: non riuscivo a togliermi dalla testa quel bidone pieno di bucce di patata. Stavo male al pensiero di aver gettato quel ben di Dio. La fame era un’ossessione e capii che non avevo scelta: dovevo provare a recuperarle. Il rischio era enorme, perché i tedeschi controllavano tutti i nostri movimenti dalle torrette, ma ormai la decisione era presa. Afferrai la mia gavetta e partii.
All’inizio strisciai pian piano lungo le baracche con molta prudenza, e mi nascosi dietro l’angolo di una di queste. Da lì vedevo il bidone, era a pochi metri, sul retro della cucina, ma non c’era più nessuna parete dietro la quale nascondermi, l’ultimo tratto era tutto allo scoperto.
Feci un bel respiro e schizzai verso la cucina, a rischio di essere falciato da una scarica di mitra. Sollevai il coperchio, affondai la mano nelle bucce, riempii la gavetta che mi ero portato e poi via di corsa. Il cuore mi batteva a mille, ma il più era fatto. Strinsi quella gavetta di bucce come se fosse la cosa più preziosa al mondo e mi diressi verso le latrine.
Lì sciacquai per bene il mio bottino, cercando di togliere tutta la terra, e finalmente tornai alla camerata. Gli altri dormivano, io mi avvicinai alla stufetta e ci posai sopra la gavetta per cuocere le bucce. Siccome non avevamo le posate, usai un pezzo di legno per macinarle ben bene fino a quando le trasformai in una specie di purea color caffè. Vista con i miei occhi di piccolo affamato, quella sbobba era una delizia da grande chef e la mangiai con un gusto che non so descrivere. Erano buonissime!
Lo feci qualche altra volta, fino a quando mi resi conto che il rischio era troppo alto e non sarei stato sempre così fortunato. Se mi avessero scoperto mi sarei beccato venticinque frustate, se non cinquanta. E te le davano davanti a tutti: ti portavano in un punto verso l’ingresso del campo, chiamavano i prigionieri a raccolta e ti frustavano a sangue. Le punizioni dovevano essere pubbliche, tutti erano costretti ad assistervi, dovevano servire da esempio.
Ma quando mangiavo la mia purea le frustate erano l’ultimo dei miei pensieri. Ero il ragazzino più felice del mondo ... "
" ... Mio padre e io non eravamo alloggiati nella stessa baracca, e nemmeno lavoravamo nella stessa squadra di prigionieri. Al mattino, quando ci chiamavano per il lavoro, si partiva in gruppi per direzioni e mansioni diverse; purtroppo non capitai mai nello stesso gruppo di mio padre: uno di qua, l’altro di là. Ma alle sei di sera, quando si rientrava, dopo aver preso la razione di pane, correvo nella sua baracca. Ricordo che dormiva al primo piano.
Ogni sera o quasi avevo una conversazione con lui, e questa era una grande soddisfazione, una fortuna immensa che non aveva quasi nessuno. Avere una persona della famiglia accanto, là dentro… Durante i nostri incontri parlavo quasi sempre io, lui stava a sentire, e alle volte mi faceva delle domandine. «Come è andata oggi?» mi chiedeva. «Dove sei stato? Sei stanco? Hai fame?» E io gli parlavo, gli raccontavo, e a mia volta gli chiedevo cosa fosse successo a lui. A volte mi spiegava i lavori che faceva, per esempio che l’avevano messo a scavare quei canali che più avanti avrei conosciuto anche io, un compito terribile. Ma non raccontava molto altro. Aveva più voglia di sapere cosa succedeva a me che non di raccontare quello che faceva lui. Mi diceva di cercare di tener duro, mi incoraggiava dicendomi che ce l’avrei fatta.
Una volta mi offrì la sua fetta di pane, mi disse di prenderla perché lui non aveva fame. E più io protestavo, più mi diceva di mangiare.
Poi mi pregava di andare a coricarmi, di riposare ... "
" ... Accanto al nostro campo di quarantena, il Lager A, c’era il Lager B. Era pieno di donne ebree di diverse nazionalità: lì erano finite tutte le ebree di Rodi selezionate per il lavoro. Forse era il loro campo di quarantena. Lo sapevamo tutti, perché di tanto in tanto riuscivamo anche a intravederle, c’era solo un filo spinato che ci divideva.
Allora ho deciso di cercarla. Quando tornavo dal lavoro, dopo essere stato da mio padre, invece di riposarmi, invece di cercare di recuperare le forze, mi mettevo a fare su e giù di fianco al reticolato tra i Lager A e B. Ero sicuro che fosse viva e sentivo anche che non era stata selezionata per andare a lavorare in un altro posto. Dovevo aver pazienza e insistere ... "
" ... E una sera, grazie a Dio, mentre guardavo, vidi una sagoma che ebbi difficoltà a riconoscere. Erano già due mesi che eravamo là.
Avevo un’immagine precisa di mia sorella. Me la ricordavo come una bella ragazza, con i vestiti colorati e i capelli lunghi. Quella sera invece mi ritrovai davanti, a una distanza di circa trenta metri, una sagoma irriconoscibile. In poco tempo era diventata completamente diversa, non credevo fosse possibile un simile cambiamento. Lucia era irriconoscibile, dimagrita al massimo, con un pigiama a righe, rasata a zero, però era lei, era lei. E anche lei mi stava cercando. Non riuscivamo a parlarci, ma comunicavamo con i segni, ci facevamo gesti di abbraccio, come a dire: «Forza, ce la faremo!». E tanti sguardi, sguardi che parlavano. Fu così che riuscii a far capire a mia sorella che nostro padre era ancora vivo.
Il Padre Eterno mi aveva dato il piacere di vederla prima che morisse. In quell’ambiente di morte questo ci dava la forza di continuare a sopravvivere.
Concordammo una specie di appuntamento: ogni volta che ci fosse stata la possibilità, ci saremmo incontrati in quel posto. Ma i nostri incontri non proseguirono per molto tempo.
Ogni volta che arrivavo nella sua baracca, mio padre mi chiedeva se avessi incontrato mia sorella: «L’hai incontrata, l’hai vista?». Gli rispondevo sempre di no, finché quel giorno: «Sì, papà, l’ho vista ieri sera!».
«L’hai riconosciuta?»
«Sì, con difficoltà…»
Da allora lui non mi parlò più. Cercai di spiegargli che avevo avuto difficoltà perché era molto dimagrita, mentre io immaginavo di trovarla in migliori condizioni. Ma lui da quel momento rimase in silenzio, ascoltava solamente. Poi, nei giorni successivi, osai chiedergli: «Papà, vieni pure te. È tua figlia!». Era la figlia che adorava, ma lui scuoteva la testa, e io in quei momenti mi arrabbiavo.
Non capivo il motivo per cui si rifiutava di vederla. Solo adesso comprendo: sapeva molto bene che da quel campo non si usciva vivi, che saremmo rimasti tutti là. Voleva ricordarsela com’era, la sua Lucia. Molte cose le ho capite con il senno di poi, ma in quel momento non riuscivo ad accettare questo cambiamento nel suo carattere, lo vedevo solo in modo negativo. Lui però sapeva molto bene che quel posto sarebbe stato la nostra tomba, l’aveva capito immediatamente. Io non l’avevo intuito subito, ero ancora un bambino, ci vuole tempo per capire… Forse non voleva dirmelo, non voleva farmi soffrire ancora di più, e quindi decise di rimanere in silenzio. Non era più quel padre che avevo conosciuto, quello di quando ero piccolo, e questo mi faceva soffrire.
Quando io gli dicevo di venire a vedere sua figlia, che stava là vicino, di vederla per l’ultima volta, lui non mi rispondeva né sì né no. Muoveva solo la testa… e questo mi procurava delusione e dolore immensi.
Com’era possibile un simile cambiamento? All’arrivo a Birkenau aveva difeso Lucia con i denti, facendosi gonfiare di botte dai tedeschi prima di lasciarla, e ora si rifiutava di venire a vederla. Può darsi che volesse ricordarsela così, sapendo che era ormai alla fine.
Una volta, preoccupato dalla magrezza di Lucia, mi presentai all’appuntamento con un fagottino. Avevo messo da parte la mia razione di pane e l’avevo avvolta in un panno. Vidi Lucia e le feci capire a gesti che le avrei lanciato qualcosa.
Feci volare il pane oltre il filo spinato e lei lo raccolse. Non appena vide di che si trattava, fece come per abbracciarmi. Poi tirò fuori anche lei un pezzo di pane, lo avvolse nel panno insieme al mio e mi rilanciò il fagotto. Aveva avuto la mia stessa idea. Anche in quelle condizioni drammatiche, volle continuare a essermi sorella e madre. In quel momento capii fino in fondo, come forse mai avevo fatto prima, l’amore che ci legava e l’affetto che lei aveva per me. Fu una delle ultime volte che la vidi.
Questi incontri non andarono avanti per molto tempo. Un giorno non la vidi più, e c’è voluto del tempo per capire che mia sorella non ce l’aveva fatta, che se n’era andata per sempre. Non volevo ammetterlo, ma poi ho dovuto arrendermi. Ho dovuto dire a me stesso di averla persa, di aver perso la cosa più cara, la cosa che adoravo di più.
A mio padre lo dissi chiaro e tondo: se non era più venuta, voleva dire che non ce l’aveva fatta. Ma lui aveva già capito tutto. E da quel momento decise di farla finita, perché tanto non ci sarebbe stata alcuna via d’uscita, nessuna.
Una sera, durante uno dei nostri incontri nella sua baracca, non mi chiese di andare a riposarmi, come faceva sempre, ma mi pregò dolcemente: «Sami, puoi fermarti ancora un po’ con me? Ho bisogno di parlarti». Non me l’aveva mai chiesto fino ad allora. Io mi sedetti accanto e lui, tenendomi stretto, mi disse che il giorno seguente non l’avrei trovato lì, ma che sarebbe andato all’ambulatorio. Sapevo benissimo cosa significava andare all’ambulatorio: voleva dire andare dritti alla camera a gas. Nessuno di quelli che erano andati lì dentro avevano fatto ritorno al campo, non li avevamo più visti. Ma lui, con un tono quasi convincente, ribadì: «Ma Sami, cosa pensi, a me non succederà. Non preoccuparti, mi cureranno. Vedrai!». Ma tutti e due sapevamo che non era così. Mi accarezzò e mi baciò più volte. Infine mi posò le mani sulla testa e mi diede la sua Berachah*.
Aveva deciso di farla finita. Lo pregai un’ultima volta di non andare, ma lui mi disse solo: «Sami, non ti devi preoccupare per me. Sami, tu mi devi promettere di tener duro, perché tu ce la farai».
Se ne andò anche lui. Erano i primi di ottobre. Mia sorella Lucia e mio padre se n’erano andati quasi insieme. Non avevo più nessuno.
Per questo ho vissuto
Sami Modiano
Berachah* = Benedizione
Dopo la morte di Lucia e del padre, Sami fa amicizia con un romano più grande di lui di due anni, Piero Terracina, entrambi si sostengono per riuscire ad andare avanti:
" ... Dopo la morte di mio padre e di mia sorella Lucia mi sentivo del tutto solo. Non avevo più avuto la possibilità di confrontarmi con una persona cara e ne sentivo un forte bisogno. Pregavo Dio perché questa situazione cambiasse in qualche modo, e la risposta alle mie preghiere fu l’incontro con Piero Terracina. Piero era un ebreo romano di due anni più grande di me; non eravamo nella stessa baracca, ma spesso capitava che lavorassimo insieme e poi la sera ci incontravamo per scambiare due parole, ci tenevamo compagnia. I miei rapporti con lui sono stati veramente fantastici: con Piero potevo parlare finalmente una lingua di casa, l’italiano, e cercavamo di farci coraggio a vicenda. Tra di noi si era creato quel contatto umano che era unico. Ci dicevamo parole di speranza, anche se poi, quando ci guardavamo in faccia, vedevamo che pian piano ci stavamo consumando come si consumano le candele
Insieme a Piero ho fatto anche uno dei lavori più angoscianti che ti potessero capitare: togliere i cadaveri dai fili spinati. La mattina i tedeschi staccavano la corrente per un po’ e sceglievano tre o quattro persone che dovevano recuperare i cadaveri, adagiarli a terra, denudarli, prenderli per la testa e per i piedi, metterli su un carretto e portarli via. Ogni giorno erano circa venti le persone che facevano quella fine, quasi tutte ridotte a scheletri. Poi su questi carretti si aggiungevano quelli che erano morti di morte naturale e si portavano davanti all’entrata dei crematori. Li lasciavamo là, per terra... "
Per questo ho vissuto
Sami Modiano
Il 17 gennaio del 1945 poiché l'Armata Rossa si stava avvicinando a Birkenau, i tedeschi decidono di spostare i deportati ad Auschwitz:
Quella sera a Birkenau venne formata una grande colonna. Me la ritrovai davanti, in piena notte. Mi fecero allineare insieme agli altri prigionieri: eravamo una massa che non riuscivo a quantificare, migliaia e migliaia di persone. Ci dovevano spostare verso Auschwitz.
Ricordo che c’erano almeno trenta centimetri di neve.
Ci incamminammo di notte, al freddo, con addosso i nostri laceri pigiami a righe.
Formavamo una lunga colonna di scheletri.
Avanzavamo in trenta centimetri di neve, con ai piedi i nostri zoccoli consumati da mesi e mesi di lavori forzati. A destra e a sinistra ci scortavano delle guardie con i loro cani pastore, mentre in coda eravamo sotto il tiro di una squadra di tedeschi con i fucili mitragliatori che facevano immediatamente piazza pulita di quelli che restavano indietro. Se il prigioniero non si rimetteva in marcia, finiva in coda alla colonna. Lì veniva falciato da una scarica di mitra.
Le chiamavano marce della morte. Non ci si poteva fermare.
Quella notte ho dato fondo a tutte le mie forze, ho marciato fino allo stremo, ma non ce l’ho fatta. Avrò camminato per due chilometri o poco più, poi mi sono arreso. Mi sono lasciato cadere. Non mi tenevo più in piedi. Feci qualche tentativo per rialzarmi, ma era inutile. Da un momento all’altro sarei arrivato in coda.
Mi fermai per terra, con le mani in testa, aspettando il colpo di grazia.
Ma poi è successo qualcosa che ancora oggi non mi spiego. Due prigionieri, anche loro con un pigiama a righe, ma forse con qualche anno e un po’ di forza in più di me, compirono un gesto che non ha una spiegazione, ma che mi salvò la vita.
In momenti come quelli ognuno di noi pensava a se stesso. La cattiveria e l’egoismo non c’entravano nulla: non aiutavi il prossimo non perché non lo volevi fare, ma perché non ne avevi le forze. Invece questi due prigionieri – che non avevo mai visto prima, due perfetti sconosciuti – si chinarono, mi sollevarono, mi presero sotto braccio e mi trascinarono per gli ultimi metri fino ad Auschwitz.
Avevo quasi perso conoscenza, non capivo nulla di quello che stava accadendo. Oltre al corpo, anche il mio cervello era partito. L’ultimo mio pensiero cosciente era stato quello di abbandonarmi, di arrendermi alla morte, e l’ultimo ricordo era quello di aver sentito che avevano smesso di trascinarmi.
Mi risvegliai da solo.
Non ho idea di quanto tempo sia rimasto incosciente. Mi ridestai su una montagna di cadaveri congelati e mi guardai intorno. Non c’era più nessuno, né prigionieri né tedeschi, né cani né Kapo. Erano partiti tutti quanti.
Intorno a me, dove mi avevano abbandonato quei due angeli, non vedevo che cadaveri dappertutto, cadaveri congelati, erano diventati duri. Realizzai subito che non potevo rimanere là, perché mi sarei congelato anch’io.
Notai a un centinaio di metri delle costruzioni di mattoni. In qualche modo ero arrivato ad Auschwitz.
Mi trascinai a quattro zampe verso quei blocchi, cercando di mettermi al riparo. Arrivato lì, mi accucciai, sfinito, su un giaciglio.
Questa fu l’ultima occasione che la morte ebbe per portarmi via così giovane. Avrei dovuto ricevere il colpo di grazia mentre ero in ginocchio nella neve, a metà strada fra Birkenau e Auschwitz. In appena tre chilometri avevano perso la vita centinaia di persone e io avrei dovuto essere uno di loro. Invece qualcosa aveva spinto questi due sconosciuti a inginocchiarsi nella neve e a trascinarmi di peso fino al campo, salvandomi la vita. Perché l’avevano fatto? Continuavo a chiedermelo. Se oggi sono qui a raccontarvi la mia storia lo devo a questi due angeli custodi ...
" ... Era la mattina del 27 gennaio 1945, nevicava. Qualcuno dentro il blocco cominciò a dire che i russi erano arrivati. Poi, finalmente, li vedemmo per la prima volta in faccia. Io li vidi dalla finestra. Un carro di legno trainato da due cavalli e un russo con il fucile mitragliatore a tamburo. Dietro al conducente, sdraiata sulla paglia, c’era una donna, una soldatessa russa. Portavano tutti il colbacco.
Arrivati ad Auschwitz non riuscivano a credere ai loro occhi. Si trovavano in difficoltà perché davanti a loro si presentava una scena che non si aspettavano.
Dappertutto era pieno di cadaveri, di scheletri e loro rimasero là impalati. Guardavano e non capivano.
Se avessero tardato anche di una settimana, credo che non ce l’avrei fatta. Ero letteralmente pelle e ossa. Il fatto che fossi ancora in grado di respirare era un miracolo.
Appena mi videro, mi portarono immediatamente all’ospedale che avevano allestito in alcuni blocchi del campo. In questo ospedale i letti erano singoli, e non eravamo in molti. La maggior parte di noi morì in pochi giorni.
Lì ritrovai Piero Terracina. Apparteneva all’ultimo gruppo di prigionieri rimasti a Birkenau ed era arrivato ad Auschwitz pochi giorni dopo di me, si era incamminato con l’ultima marcia. Mi raccontò che dopo la partenza dei prigionieri, i tedeschi avevano via via abbandonato il campo e avevano distrutto le torrette di guardia per farne legna da ardere, ma anche quello non bastava. Inoltre non c’era più nulla da mangiare. Si beveva la neve e si strappava qualche radice per fermare lo stomaco. Poi il 21 gennaio si era presentata al campo una colonna tedesca per radunare gli ultimi prigionieri e portarli chissà dove. Molti di quelli non più in grado di camminare vennero falciati sul posto.
Piero riusciva ancora a stare in piedi ed era stato inserito nella marcia della morte partita da Birkenau, ma subito dopo aveva tentato la fuga insieme a un gruppetto di suoi giovani amici italiani e greci. Approfittando del buio pesto e della distrazione dei tedeschi – ormai erano nel pieno della disfatta – si erano buttati fuori strada. Erano rimasti immobili nella neve per ore, fino a quando furono certi che i soldati non li stessero cercando. Poi si erano incamminati senza meta, vagando a vuoto per ore nella neve. A un tratto avevano scorto in lontananza il profilo di alcuni edifici. Non sapevano cosa avrebbero trovato, ma era troppo freddo per girovagare ancora. Arrivati a destinazione capirono di essere ad Auschwitz: avevano impiegato non so quante ore per coprire una distanza di tre chilometri ... "
" Da Auschwitz ci inviarono direttamente al fronte, sul territorio della Germania, dove l’esercito sovietico stava per sfondare. Il genio militare doveva lavorare proprio dietro la prima linea dell’Armata Rossa. In previsione di un contrattacco da parte dei tedeschi, noi dovevamo scavare delle trincee.
Il lavoro era duro, ma equamente distribuito. Noi mille italiani eravamo suddivisi in squadre da dieci, ciascuna capeggiata da un geniere sovietico. Ognuno doveva scavare quindici metri di trincea al giorno, un metro e dieci di profondità per un metro e dieci di larghezza.
Tutti dovevano fare la propria parte: il geniere russo che guidava la nostra squadra, dopo aver controllato che noi svolgessimo il nostro compito, doveva scavare esattamente quanto noialtri ...
" ... Ho scavato trincee per due mesi. L’8 maggio la guerra era finita.
A quel punto noi italiani eravamo pronti per mollare le vanghe, ma dopo un paio di giorni di riposo totale, ci arrivò un nuovo ordine. Dovevano trasportarci tutti sul fiume Oder.
I tedeschi avevano fatto saltare i ponti e l’Armata Rossa non poteva far ritorno.
Ci mettemmo al lavoro e creammo due ponti provvisori in legno. Da lì facevano passare anche materiale bellico che volevano far arrivare in Russia ... "
Per questo ho vissuto
Sami Modiano
Sami e l'amico Settimio vengono poi spostati in Polonia nella caserma di Opole e qui decidono di scappare:
" ... Partimmo una notte di fine agosto. Settimio aveva studiato attentamente le mappe rubate nella caserma dei polacchi e aveva disegnato il percorso con una cura estrema. Il suo piano era perfetto, ma allora non potevo certo saperlo. Anzi, sulle prime ero convinto del contrario. Anche a viaggio iniziato, l’idea di lasciare Opole e le comodità della caserma continuava a sembrarmi davvero folle. A mettermi a disagio non era la paura di essere scoperti o l’eccitazione della fuga. Ero semplicemente stupito dalla decisione di Settimio: lasciare la tranquillità della caserma e la sicurezza di un pasto caldo per fare un vero e proprio salto nel buio.
Eppure qualcosa mi diceva che la convinzione di quel ragazzo mi avrebbe portato lontano: a casa, al sicuro. La sua voglia di scappare e la sua determinazione erano contagiose. Anche se non comprendevo le sue ragioni, sentivo di doverlo seguire. Mi ero completamente abbandonato alla sua volontà: lui decideva e io gli andavo dietro. Aveva detto «Andiamo!» e io, quasi senza rendermene conto, raccolsi un po’ di cibo in scatola e mi misi in marcia ... "
Per questo ho vissuto
Sami Modiano
Con grande fatica riescono a raggiungere Roma e qui inizia quella nuova fase della vita che porterà Sami a essere uno dei custodi della memoria:
" ... Io ho avuto tante sfortune nella vita, ma anche la buona sorte di trovare una compagna che mi ha capito sin dall’inizio. Una ragazza giovane e bella come Selma avrebbe potuto stancarsi di me e rifarsi una vita. E invece, dopo oltre cinquant’anni di matrimonio, è ancora qui con me.
Grazie alla sua insistenza ho trovato la forza e la voglia di aprirmi. Sulle prime ho cominciato a parlare timidamente con chi mi era vicino, non tanto per rivelare la mia storia quanto per cercare risposte alle mie domande. Ho raccolto le testimonianze dei miei parenti più stretti e sono venuto a sapere tutto quello che ad Auschwitz non avevo visto o voluto vedere ... "
" ... La mia testimonianza serve a questo. A coltivare la memoria e a ricordare chi non è più con noi: tutte quelle persone che sono finite nelle camere a gas o che non hanno resistito al gelo delle notti di Auschwitz. Io oggi parlo per loro ... "
Per questo ho vissuto
Sami Modiano
Io non sono uscito da Birkenau, io sono ancora là...
Sami Modiano